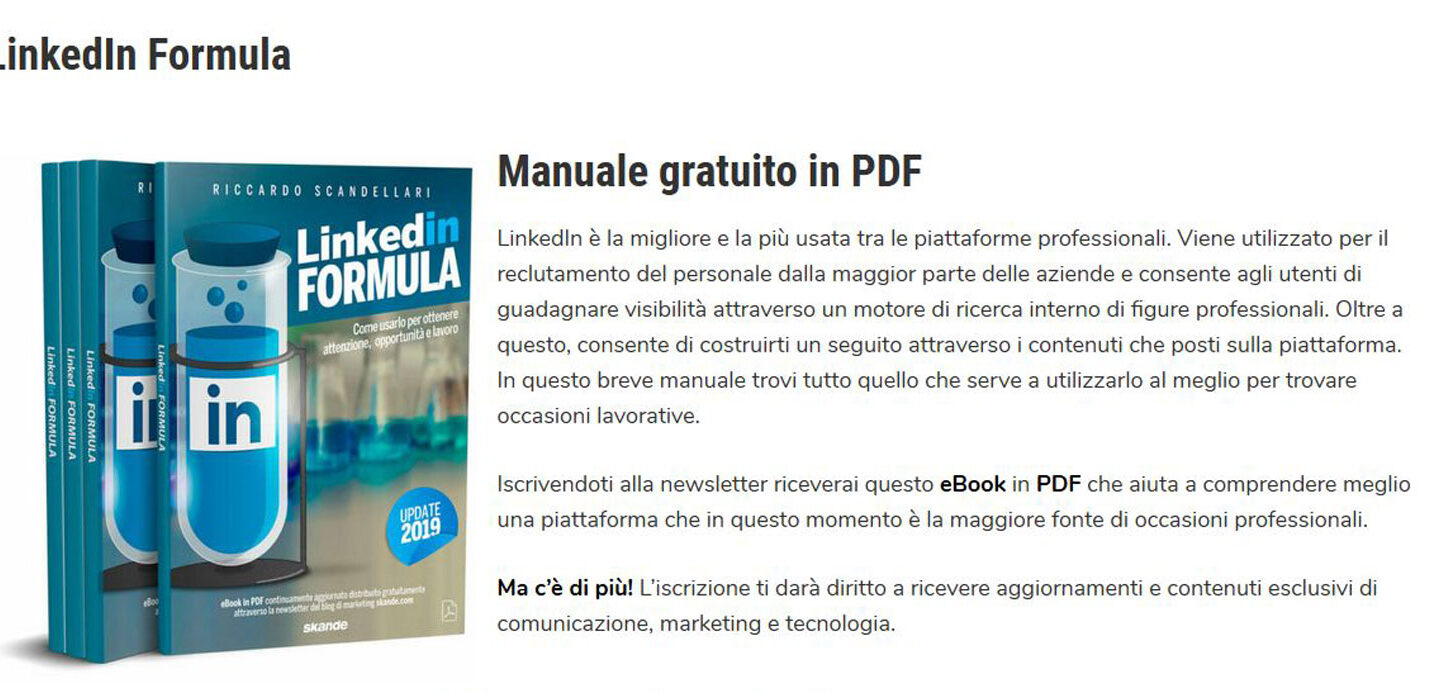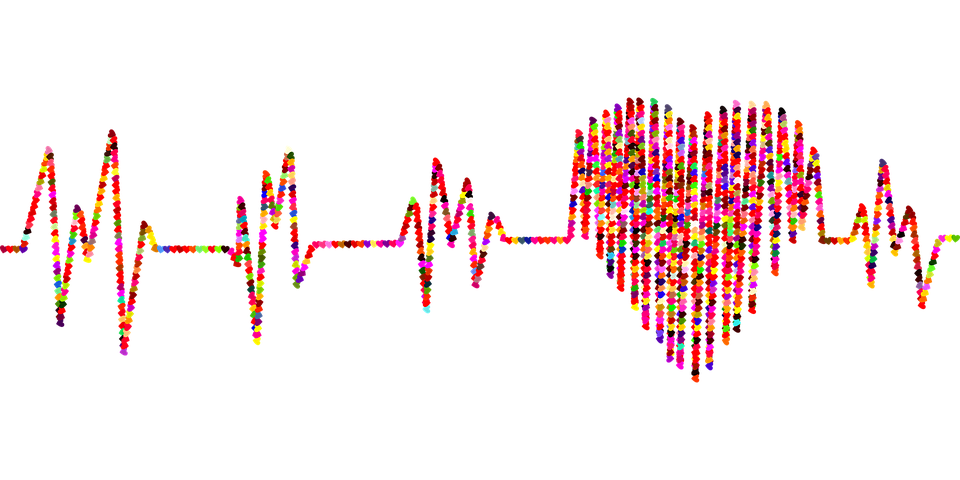La ricerca della nostra miglior versione non può prescindere dal saper guardare a ciò che non abbiamo e che, di conseguenza, non siamo in grado di dare.
Nel descrivere noi stessi, o presentando i nostri servizi e in generale, quando parliamo ai nostri contatti (siano essi prospect o clienti, la nostra audience, insomma), vogliamo comunicare i nostri tratti migliori, facciamo sì di trasmettere positività, diamo risalto ai nostri punti di forza.
E sono proprio quei famigerati punti di forza ciò che ci viene richiesto di rappresentare. Pensate ad esempio ad un colloquio di lavoro: vi avranno probabilmente chiesto in più di un’occasione di elencarli e motivarli.
Ma chi di voi ha mai provato a parlare senza tabù e con onestà delle proprie lacune? Chi ha fatto almeno una volta l’esercizio di indagare punti deboli, carenze e mancanze?
Non parlo di una banale lista di cose che non ci piacciono di noi o che ci mancano: le liste servono solo a creare un senso di urgenza e ci danno l’illusione di aver assolto ad un onere.
Parlo di un ragionamento profondo che passi in rassegna e analizzi i timori, gli insuccessi, le rinunce, il rifiuto, l’ignoranza…
Il debito verso noi stessi.
La ricerca della nostra miglior versione non può prescindere dal saper guardare a ciò che non abbiamo e che, di conseguenza, non siamo in grado di dare.
Il cammino per il miglioramento passa dal fango.
E bisogna sporcarsi le mani, di tanto in tanto (o i piedi, se preferite).
Sono portata a pensare che possa essere di grande beneficio esercitarci ad abbandonare talvolta la proiezione vincente e positivistica che ci siamo disegnati attorno.
Attraversare il fango ogni tanto ci permette di distrarci dall’ebbrezza che il calice del successo ci promette.